
Caratteristiche dell'orbitolino, habitat, alimentazione, riproduzione
Orbitolin Era un genere di protisti che oggi è estinto. Faceva parte dei cosiddetti foraminiferi, in particolare dei macroforaminiferi per le sue dimensioni. Questo gruppo prende il nome dalla complessa rete di forami e reticoli che possono essere visti all'interno dei loro gusci..
Secondo i reperti fossili, gli orbitolini vissero nel periodo Cretaceo dell'era mesozoica. Alla fine di quel periodo si estinsero. Le ragioni di ciò sono ancora allo studio degli specialisti, poiché molti altri foraminiferi sono riusciti a perpetuarsi ancora di più sulla Terra, anche ai giorni nostri.

Furono descritti per la prima volta nel 1850 dal naturalista francese Alcide d'Orbigny. Si tratta di un interessante gruppo di organismi, poiché costituiscono un esempio rappresentativo dei membri del regno protista, che, cioè, rimane per molti aspetti ancora sconosciuto a chi si dedica al suo studio..
Indice articolo
- 1 Caratteristiche
- 2 Tassonomia
- 3 Morfologia
- 4 Habitat e distribuzione
- 5 Cibo
- 6 Riproduzione
- 7 Riferimenti
Caratteristiche
Gli organismi che componevano il genere Orbitolin erano unicellulari. Ciò significa che erano costituiti da una singola cellula, che svolgeva tutte le funzioni svolte dagli esseri viventi..
Allo stesso modo, poiché faceva parte del regno protista, erano una delle cellule eucariotiche più primitive. Ciò significa che avevano un nucleo all'interno del quale è stato trovato il loro materiale genetico (DNA), formando i cromosomi..
Erano organismi che vivevano liberamente, non formavano colonie. Inoltre, le orbitoline appartenevano al gruppo dei foraminiferi agglutinanti. Ciò implicava che costruissero il loro guscio, con l'aiuto dei loro pseudopodi, che raccoglievano particelle sedimentarie per questo scopo..
Allo stesso modo, le orbitoline erano organismi eterotrofi perché non erano in grado di sintetizzare i loro nutrienti, ma dovevano prenderli dall'ambiente che li circondava, sia dalle alghe che da altri tipi di organismi..
Infine, si ritiene che gli orbitolini abbiano trascorso la maggior parte della loro vita immobili nel substrato marino, fissato ad esso. Anche se a volte potrebbero muoversi con l'aiuto dei loro pseudopodi e percorrere brevi distanze.
Tassonomia
La classificazione tassonomica del genere Orbitolin è il prossimo:
-Dominio: Eukarya
-Regno protista
-Bordo: Rhizaria
-Classe: Foraminiferi
-Ordine: Textulariida
-Sottordine: Textularina
-Superfamiglia: Orbitolinoidea
-Famiglia: Orbitolinidae
-Sottofamiglia: Orbitolininae
-Genere: Orbitolin (Estinto)
Morfologia
Come è prevedibile in tutti i foraminiferi, quelli del genere Orbitolin Erano costituiti da una cellula dall'aspetto ameboide che era protetta da un guscio esterno o da uno scheletro.
La cellula è stata divisa in due parti: endoplasma ed ectoplasma. L'endoplasma era completamente protetto dal guscio del protista e al suo interno c'erano tutti gli organelli di cui questo organismo necessitava per poter svolgere tutte le sue funzioni vitali, come la digestione..
D'altra parte, l'ectoplasma circondava praticamente l'intero guscio e da questo è che si sono formati gli pseudopodi che hanno permesso all'organismo di ottenere il suo cibo e persino di potersi muovere attraverso il substrato, che, secondo gli specialisti, essi ha battuto molto basso.

Per quanto riguarda la conchiglia, i fossili hanno permesso di stabilire che diventassero grandi, rispetto ad altri foraminiferi.
I gusci degli organismi di questo genere avevano un diametro di circa 2 cm. Aveva una forma conica che ricordava i tipici cappelli cinesi.
Internamente il guscio presentava una serie di tramezzi, sia verticali che orizzontali, che lo dividevano in piccoli scomparti
Habitat e distribuzione
Come con la maggior parte degli organismi foraminiferi, le orbitoline erano ampiamente distribuite in tutta la geografia mondiale. Erano animali puramente marini, il che significa che sono stati trovati solo in acque salmastre.
Oltre a questo, si trovavano principalmente in acque vicine ai tropici, poiché non si sviluppavano molto bene in acque a bassa temperatura..
Secondo gli specialisti, le orbitoline erano considerate organismi bentonici e neritici. Ciò implica che si trovavano specificamente nella zona di confine tra la costa e la piattaforma continentale. Tutto ciò significa che questi organismi hanno avuto un'esposizione moderata alla luce solare..
Tenendo conto che chi si è dedicato allo studio di questi organismi presume che siano bentonici, allora sembra corretto affermare che gli orbitolini si trovavano in quello che è noto come benthos, cioè si trovavano sul fondo del fondale marino. , molto vicino al substrato..
Alimentazione
La dieta dei membri di questo genere dipendeva dalla disponibilità di cibo e sostanze nutritive nell'ambiente in cui si sviluppavano. In questo senso, potevano nutrirsi dei resti di alghe, così come di alcuni batteri che erano alla loro portata..
Allo stesso modo, si nutrivano anche di particelle sospese nelle correnti, motivo per cui sono anche considerati sospensivori..
Ora, il processo di alimentazione era molto simile a quello della maggior parte dei protisti. Questi fanno uso delle diverse proiezioni emesse dal loro citoplasma per catturare particelle di cibo o possibili prede..
I protisti del genere Orbitolin emettevano pseudopodi che permettevano loro di intrappolare o racchiudere particelle di cibo per incorporarle nel loro citoplasma in questo modo. Gli specialisti ritengono che le orbitoline seguissero lo stesso schema di alimentazione dei protisti attuali.
Cioè, nel suo endoplasma conteneva vescicole all'interno delle quali c'erano enzimi digestivi che aiutavano nel processo di degradazione del cibo ingerito.
Una volta che questi enzimi hanno degradato il cibo e la cellula ha metabolizzato e assorbito ciò che gli era utile, i rifiuti venivano rilasciati nello stesso modo in cui sono entrati, attraverso le vescicole. Questi si sono fusi con la membrana plasmatica e hanno rilasciato il loro contenuto all'esterno. Questo è lo stesso processo seguito dai protisti moderni..
Riproduzione
Tenendo conto che le informazioni disponibili su questo genere provengono dai fossili che sono stati raccolti, per quanto riguarda la loro riproduzione, è possibile solo fare congetture o approssimazioni basate sulla conoscenza degli attuali foraminiferi bentonici..
In questo senso, è noto che i membri del genere Orbitolin appartenevano al gruppo dei macroforaminiferi e come tali presentavano, nel loro ciclo vitale, entrambi i tipi di riproduzione: sessuale e asessuata.
Ora, durante il loro ciclo di vita, questi organismi hanno presentato un'alternanza di generazioni, essendo queste rappresentate da una generazione aploide (gamonte) e da un'altra.
Ciò che è accaduto durante il suo ciclo di vita è stato che il gamonte ha subito diversi processi di divisione, attraverso i quali ha dato origine a numerosi gameti, che sono stati diflagellati. Questo è importante perché ha permesso loro di muoversi liberamente nell'ambiente acquatico. Questi si fusero per dare origine a uno zigote, che in seguito divenne una struttura diploide nota come schizonte..
Lo schizonte aveva diversi nuclei ed era più grande del gamonte. Infine, lo schizonte ha sperimentato diverse divisioni meiotiche per dare origine a gamonti e quindi riavviare il ciclo.
Riferimenti
- Curtis, H., Barnes, S., Schneck, A. e Massarini, A. (2008). Biologia. Editoriale Médica Panamericana. 7a edizione.
- Foraminiferi. Estratto da: regmurcia.com
- Gorog, A. e Arnaud, A. (1996). Cretaceo inferiore Orbitolin dal Venezuela. Micropaleontologia. 42 (1)
- Kaminski, M.A. (2004). La classificazione dell'anno 2000 dei foraminiferi agglutinati. In: Bubík, M. & Kaminski, M.A. (a cura di), Atti del Sesto seminario internazionale sui foraminiferi agglutinati. Pubblicazione speciale della Fondazione Grzybowski
- Loeblich, A.R., Jr. e Tappan, H. (1987). Foraminiferi generali e loro classificazione. Van Nostrand Reinhold Company (ed.), 2 vol..
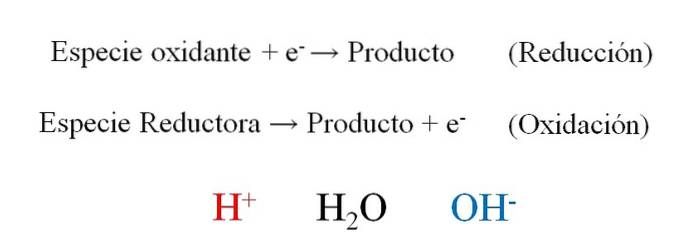

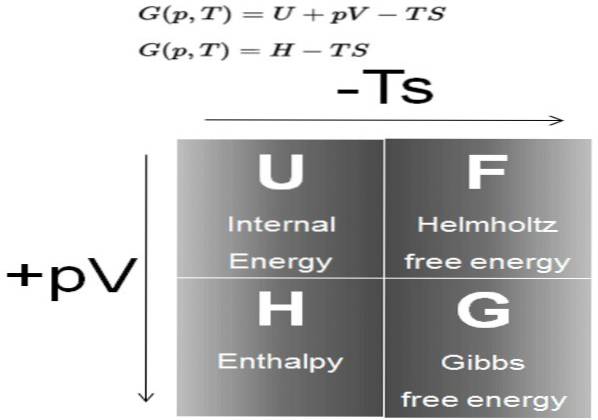
Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.