
Origine, caratteristiche, rappresentanti e opere del culteranismo

Il culteranismo Era una tendenza estetica all'interno del movimento barocco dell'età dell'oro spagnola, la cui complessità nella forma e nella struttura rendeva i suoi contenuti molto difficili da capire..
Questa corrente proponeva l'uso della metafora pura in un linguaggio fiorito ed enigmatico, che nascondeva significati e messaggi delle forme espressive tipiche della lirica, del teatro e dell'oratorio, privilegiando la struttura. Questo era ciò che i modernisti ermetici e preziosi chiamavano "arte per l'arte"..

La risorsa della latinizzazione del linguaggio può essere percepita anche come un ritorno agli scrittori dell'antichità, una retorica sintattica che sfidava l'intelligenza smantellando, attraverso un processo cognitivo sensoriale, le immagini poetiche di un linguaggio sinestetico e corazzato soggetto all'esperienza individuale.
Questo movimento è emerso alla fine del XVI secolo e all'inizio del XVII. Si chiamava gongorismo a causa di uno dei suoi esponenti più prolifici, Luis de Góngora y Argote, un prete, drammaturgo e poeta spagnolo la cui penna barocca ha forgiato una nuova lingua, accessibile solo all'élite colta del suo tempo..
Indice articolo
- 1 Origine
- 2 caratteristiche
- 2.1 Complessità sintattica
- 2.2 Piccolo suggerimento semantico
- 2.3 Specularità nella sintassi
- 2.4 Latinizzazione della sintassi
- 2.5 Uso di dispositivi letterari ornamentali
- 2.6 Evasione e allusione permanenti
- 2.7 Intertestualità
- 3 Rappresentanti e opere
- 3.1 Luis de Góngora y Argote (1561-1627)
- 3.2 Juan de Tassis Peralta, conte di Villamediana (1582-1622)
- 3.3 Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)
- 4 Riferimenti
fonte
Etimologicamente, la parola culteranismo deriva dagli aggettivi: culto e luterano. Il culteranismo ha avuto origine nella letteratura barocca, tra il XVI e il XVII secolo.
In precedenza, l'eredità rinascimentale aveva concesso alle successive generazioni letterarie una serie di precetti sull'equilibrio che doveva esistere tra la forma e la sostanza dell'opera..
L'irrequietezza dello spirito umano ha cominciato a sperimentare la necessità di spezzare le catene della formalità e le esigenze del canone letterario. I creatori hanno sentito l'impulso a perseguire nuove proposte estetiche che sbilanciavano l'equilibrio classico richiesto nella composizione durante il Rinascimento..
Quindi la nozione moderna di estetica letteraria del tempo nacque dalla mano di Luis de Góngora y Argote. Il barocco ha lasciato il posto a una proposta che rifletteva sulle risorse liriche e poetiche in modo ingegnoso, acuto e impenetrabile.
L'oggetto delle poesie era avvolto in piani e strutture verbali che davano priorità alla forma rispetto al contenuto; infine il tema gongoriano è stato visto attraverso tecniche speculari che proponevano la poesia come riflesso dell'essenza umana, dell'alterità e dell'ideale dell'uomo dall'esperienza del subconscio.
Caratteristiche
Le caratteristiche del culteranismo davano una visione diversa del fatto poetico, che veniva assunto come atto estetico che rispondeva ai canoni di una preziosa linguistica.
C'era una gestione discrezionale della grammatica e dell'oggetto dell'opera come esercizio espressivo-riflessivo e persino idealistico della visione personale del mondo, usando il linguaggio come specchio della realtà.
Si cercava il dinamismo, il confronto sensoriale e l'iperbolizzazione della realtà. C'è stato un netto rifiuto del linguaggio semplice e dell'equilibrio del Rinascimento.
Originalità e ingegno hanno provocato neologismi, giochi verbali e distorsioni che hanno sfidato il consolidato, mettendo alla prova l'intelligenza e la rigidità di lettori colti. Tra le principali caratteristiche di questo stile letterario, spiccano:
Complessità sintattica
L'ordine delle parole rompe con la struttura naturale. Suggerisce una relazione di dipendenza tra le frasi che crea difficoltà nella decodifica del messaggio (ipotassi).
Piccolo suggerimento semantico
La lunghezza della sintassi e la subordinazione delle parole nascondono l'idea che vuoi trasmettere. Decifrare il messaggio richiede intelligenza e un complesso processo cognitivo.
Specularità nella sintassi
Si ottiene attraverso l'opposizione di immagini poetiche. È un chiaroscuro in cui l'interazione tra risorse come la sinonimia e l'antimonio, tra le altre, suggerisce il contrasto tra la visione idealistica e realistica dell'esistenza..
Latinizzazione della sintassi
La rottura dell'ordine grammaticale è generata dall'uso eccessivo di iperbaton e altre risorse. Inoltre, venivano usati i latinismi, che non erano comuni nonostante il fatto che nel Rinascimento fossero noti ai lettori istruiti.
Allo stesso modo, le trasposizioni e gli atavismi linguistici delle costruzioni classiche hanno rafforzato l'intenzione cultista degli autori..
Uso di dispositivi letterari ornamentali
C'è la presenza di un linguaggio fiorito, contrastante, sonoro ed esagerato. Emergono versi carichi di audaci immagini sensoriali, come metafore, allitterazioni, epiteti ed ellissi. Sono comuni anche aggettivi cromatici e parole ritmiche e sonore..
Evasione e allusione permanenti
C'era la necessità di fuggire dal mondo contemporaneo ed è stato raggiunto attraverso allusioni alla mitologia e ad altre culture. Il modello classico rinascimentale è stato rotto e è stato creato un nuovo mondo in cui la cosa più importante era il modo di esprimere la realtà.
Intertestualità
Si stabilì un rapporto diretto tra testi di autori antichi e moderni, e l'alto livello di conoscenza e natura colta dell'autore, che rifletté sulla lirica e propose in modo audace cambiamenti drastici, che scossero le norme stabilite.
Rappresentanti e opere
Luis de Góngora y Argote (1561-1627)
È nato a Córdoba, in Spagna, ed è stato il principale promotore di questa tendenza. I suoi detrattori lo hanno fortemente criticato per aver osato sfidare le norme stabilite dall'accademismo sul modo in cui dovrebbe essere svolto l'esercizio creativo letterario..
Fu uno scrittore controverso riguardo al rinnovamento dello stile poetico del XVII secolo. Aspirava a creare un linguaggio che si distinguesse dall'espressione chiara e ordinaria.
Rinnovò le risorse della lingua rinascimentale e incorporò i colpi di scena della lingua latinizzata, proponendo la creazione poetica come strumento linguistico libero da atavismi grammaticali formali.
L'oscurità semantica a Góngora era dovuta alla sua tendenza alla decostruzione retorica e linguistica, che conferiva ai suoi contenuti un carattere enigmatico.
Il linguaggio ermetico suggerisce l'impenetrabilità dell'autore che ha discusso i temi della vita, un prodotto dell'evasione e dell'estraniamento che ha sperimentato durante il processo creativo. Questa è la prova dell'influenza di questa corrente sull'autore.
Góngora è stato l'autore di un gran numero di sonetti, romanzi, décimas, letrillas e canzoni. Tra le principali poesie che ha scritto, spiccano le seguenti:
Favola di Polifemo e Galatea
Poema epico il cui elemento moderno consisteva nel non essere stato scritto per moralizzare. Senza alcuna intenzione didattica, l'autore ha narrato l'amore di Polifemo, il Ciclope, per Galatea, la ninfa che lo respingeva per aspetto e brutalità.
La descrizione sposta l'espressione narrativa per evidenziare l'elemento plastico della storia. L'autore ha mostrato una tecnica preziosa e ampollosa di alte dimensioni colte.
Ha incoraggiato deliberatamente l'uso di risorse fonetiche e metafore elaborate, che hanno migliorato l'intenzione estetica e la deificazione del linguaggio come entità creativa in sé.
Panegirico dedicato al Duca di Lerma
Opera il cui genere elogiativo salva l'adulazione poetica al sovrano. Con questo, Góngora ha esaltato la reputazione degli aristocratici barocchi.
Solitudine (incompiuto)
Fu l'opera emblematica del culteranismo, poiché la sua narrazione scivola in una struttura intricata piena di ornamenti poetici e intrecci linguistici labirintici..
Il suo contenuto ruota intorno all'idealizzazione della natura, che si contrappone all'ambiente cortese stridente e licenzioso.
Juan de Tassis Peralta, conte di Villamediana (1582-1622)
Scrittore spagnolo di origine portoghese. La sua fama nella vita derivava dai suoi eccessi, un'esistenza compulsiva e una morte tragica. La sua opera poetica è stata una sintesi equilibrata tra le due correnti dominanti del barocco: culteranismo e conceptismo. Le sue opere più rilevanti sono le seguenti:
Favola di Phaethon
Un'opera degna rappresentante dei poeti culteranisti d'oro, ampia e complicata da capire, con un ermetismo tipico dello stile.
Quest'opera fa addirittura riferimento al suo tema, che allude all'opera mitica di Ovidio contenuta in Metamorfosi. È un poema accademico che esalta le forme gongorine, poiché la sua struttura è simile a quella del Favola di Polifemo e Galatea.
Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)
Calderón de la Barca era un drammaturgo e poeta spagnolo; Faceva anche parte dell'esercito e fece carriera militare. Con uno stile raffinato, la proposta estetica della sua opera teatrale era più poetica e intellettuale, con una spiccata intenzione didattica che godeva di un linguaggio colto.
La musicalità e l'eleganza dei suoi testi rispondevano all'ideale della bellezza culteranista, ma il suo lavoro era anche impregnato di concettualismo poiché dà importanza al contenuto.
Si può apprezzare anche l'accurata proposta scenografica plastica che ha sempre sviluppato. Nei suoi dettagli spiccava l'elemento simbolico-sensoriale..
La vita è un sogno
Il tema principale di quest'opera pubblicata nel 1635 ruota attorno al fatto che l'uomo ha il potere di plasmare liberamente la propria vita, chi non è governato dal destino.
La sua struttura è divisa in tre atti. Il contenuto drammatico di quest'opera è pieno di giochi di parole e altre risorse letterarie che mostrano la complessità della società di quel tempo, nel rispetto della proposta estetica del barocco.
Il grande teatro del mondo
Si tratta di un auto sacramentale scritto nel 1655 che si svolge in un atto unico, il cui tema centrale è la vita come un grande teatro dove ogni individuo rappresenta un personaggio.
L'autore ha esaltato l'idea dell'importanza del fare del bene e presenta l'idea della morte come un equalizzatore sociale. Questo argomento ha riferimenti antichi (è stato trattato da Platone, Epitteto e gli stoici, tra gli altri), e Calderón lo salva come soggetto di riflessione inquadrato nel fatto religioso.
Riferimenti
- Abreu, G. Ermilo "La sintassi e l'espressione letteraria" in Riviste Filologiche. Estratto il 5 aprile 2019 da Filological Magazines: magazines-filologicas.unam.mx
- "Gongorismo" in Wikipedia, l'enciclopedia libera. Estratto il 5 aprile 2019 da Wikipedia, l'enciclopedia libera: es.wikipedia.org
- Mollfulleda, Santiago “Sull'opposizione tra culteranismo e conceptismo in Universitas Tarraconensis Revista de philología. Estratto il 5 aprile 2019 da Universitas Tarraconensis Revista de philología: revistes.urv.cat
- Borges, J. "La metafora speculare: echi dell'esistenzialismo schopenhaueriano in" Gli specchi "di Scielo. Estratto il 5 aprile 2019 da Scielo: scielo.conicyt.cl
- Harlan, Crystal "Culteranismo" in About Spanish. Estratto il 6 aprile 2019 da About español: aboutespanol.com
- "La poesia del secolo d'oro (SXVII)" in castigliano Rincón. Estratto il 6 aprile 2019 da Rincón castellano: rinconcastellano.com
- "Il Conte di Villamediana" nella Storia della Spagna e del mondo. Estratto il 6 aprile 2019 da Storia della Spagna e del mondo: historiaespanaymundo.com

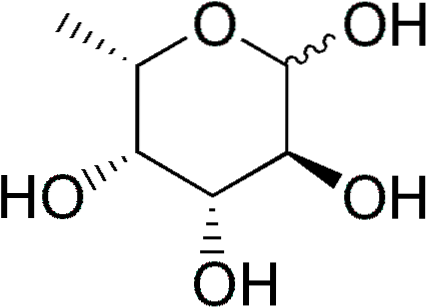
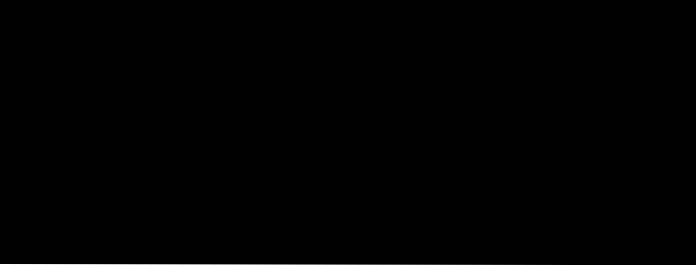
Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.