
Struttura, tipi e loro funzioni dei recettori muscarinici, antagonisti
Il recettori muscarinici Sono molecole che mediano l'azione dell'acetilcolina (ACh) e si trovano nella membrana postsinaptica delle sinapsi in cui viene rilasciato detto neurotrasmettitore; il suo nome deriva dalla sua sensibilità all'alcaloide muscarino prodotto dal fungo Fly agarico.
Nel sistema nervoso centrale ci sono diversi assemblaggi neuronali i cui assoni rilasciano acetilcolina. Alcuni di loro finiscono nel cervello stesso, mentre la maggior parte costituisce le vie motorie per il muscolo scheletrico o le vie effettive del sistema nervoso autonomo per le ghiandole e la muscolatura cardiaca e liscia..

L'acetilcolina rilasciata alle giunzioni neuromuscolari del muscolo scheletrico attiva i recettori colinergici chiamati recettori nicotinici, a causa della loro sensibilità all'alcaloide nicotina, che si trovano anche nelle sinapsi gangliari del sistema nervoso autonomo (ANS)..
I neuroni postgangliari della divisione parasimpatica di questo sistema esercitano le loro funzioni rilasciando acetilcolina, che agisce sui recettori colinergici muscarinici situati sulle membrane delle cellule effettrici e inducendo in essi modificazioni elettriche dovute a cambiamenti di permeabilità nei loro canali ionici.

Indice articolo
- 1 Struttura
- 2 Tipi di recettori muscarinici e loro funzioni
- 2.1 - Ricevitori M1
- 2.2 - Ricevitori M2
- 2.3 - Ricevitori M3
- 2.4 - Ricevitori M4 e M5
- 3 antagonisti
- 4 Riferimenti
Struttura
I recettori muscarinici appartengono alla famiglia dei recettori metabotropici, termine che designa quei recettori che non sono propriamente canali ionici, ma piuttosto strutture proteiche che, quando attivate, innescano processi metabolici intracellulari che modificano l'attività dei canali veri..
Il termine viene utilizzato per differenziarli dai recettori ionotropici, che sono veri e propri canali ionici che si aprono o si chiudono per azione diretta del neurotrasmettitore, come è il caso dei recettori nicotinici già citati nelle placche neuromuscolari del muscolo scheletrico..
All'interno dei recettori metabotropi, i recettori muscarinici sono inclusi nel gruppo noto come recettori accoppiati a proteine G, perché a seconda del loro tipo, la loro azione è mediata da alcune varianti di detta proteina, come Gi, un inibitore dell'adenil ciclasi, e Gq o G11 che attivano la fosfolipasi C (PLC).
I recettori muscarinici sono proteine di membrana integrali lunghe; hanno sette segmenti transmembrana composti da alfa eliche, che attraversano sequenzialmente il doppio strato lipidico della membrana. All'interno, sul lato citoplasmatico, si associano alla corrispondente proteina G che trasduce l'interazione ligando-recettore.
Tipi di recettori muscarinici e loro funzioni
Sono stati identificati almeno 5 tipi di recettori muscarinici e sono designati utilizzando la lettera M seguita da un numero, ovvero: M1, M2, M3, M4 e M5.
I recettori M1, M3 e M5 formano la famiglia M1 e sono caratterizzati dalla loro associazione con le proteine Gq o G11, mentre i recettori M2 e M4 sono della famiglia M2 e sono associati alla proteina Gi.
- Ricevitori M1
Si trovano principalmente nel sistema nervoso centrale, nelle ghiandole esocrine e nei gangli del sistema nervoso autonomo. Sono accoppiati alla proteina Gq, che attiva l'enzima fosfolipasi C, che converte il fosfatidil inositolo (PIP2) in inositolo trifosfato (IP3), che rilascia Ca ++ intracellulare, e diacilglicerolo (DAG), che attiva la proteina chinasi C.
- Ricevitori M2
Si trovano principalmente nel cuore, principalmente nelle cellule del nodo senoatriale, su cui agiscono diminuendo la loro frequenza di scarica, come descritto di seguito..
Automatismo cardiaco
I recettori M2 sono stati studiati in modo più approfondito a livello del nodo senoatriale (SA) del cuore, luogo dove normalmente si manifesta l'automaticità che periodicamente produce le eccitazioni ritmiche responsabili dell'attività cardiaca meccanica.
Le cellule del nodo senoatriale, dopo ogni potenziale d'azione (AP) che innesca una sistole cardiaca (contrazione), si ripolarizzano e ritornano al livello di circa -70 mV. Ma la tensione non rimane a quel valore, ma subisce una progressiva depolarizzazione ad un livello di soglia che innesca un nuovo potenziale d'azione.
Questa progressiva depolarizzazione è dovuta a variazioni spontanee delle correnti ioniche (I) che includono: riduzione dell'uscita K + (IK1), comparsa di una corrente di ingresso di Na + (If) e quindi di un ingresso di Ca ++ (ICaT), fino a raggiunge la soglia e innesca un'altra corrente Ca ++ (ICaL) responsabile del potenziale d'azione.
Se l'uscita K + (IK1) è molto bassa e le correnti di ingresso Na + (If) e Ca ++ (ICaT) sono alte, la depolarizzazione avviene più velocemente, il potenziale d'azione e la contrazione si verificano prima e la frequenza cardiaca è più alta. Modifiche contrarie in queste correnti abbassano la frequenza.
I cambiamenti metabotropici indotti dalla noradrenalina (simpatico) e dall'acetilcolina (parasimpatico) possono alterare queste correnti. CAMP attiva direttamente i canali If, la proteina chinasi A (PKA) fosforila e attiva i canali Ca ++ di ICaT e il gruppo βγ della proteina Gi attiva l'output K+.
Azione muscarinica M2
Quando l'acetilcolina rilasciata dalle terminazioni postgangliari delle fibre cardiache vagali (parasimpatiche) si lega ai recettori muscarinici M2 delle cellule del nodo senoatriale, la subunità αi della proteina Gi cambia il suo PIL per GTP e si separa, liberando il blocco βγ.
La subunità αi inibisce l'adenil ciclasi e riduce la produzione di cAMP, che riduce l'attività dei canali If e PKA. Quest'ultimo fatto riduce la fosforilazione e l'attività dei canali Ca ++ per ICaT; il risultato è una riduzione delle correnti depolarizzanti.
Il gruppo formato dalle subunità βγ della proteina Gi attiva una corrente K + verso l'esterno (IKACh) che tende a contrastare gli input di Na + e Ca ++ e abbassa il tasso di depolarizzazione..
Il risultato articolare è una riduzione della pendenza della depolarizzazione spontanea e una riduzione della frequenza cardiaca..
- Ricevitori M3

Si trovano nella muscolatura liscia (apparato digerente, vescica, vasi sanguigni, bronchi), in alcune ghiandole esocrine e nel sistema nervoso centrale.
Sono inoltre accoppiati alla proteina Gq e, a livello polmonare, possono provocare broncocostrizione, mentre agendo sull'endotelio vascolare rilasciano ossido nitrico (NO) e provocano vasodilatazione..
- Ricevitori M4 e M5
Questi recettori sono meno caratterizzati e studiati dei precedenti. La sua presenza è stata segnalata nel sistema nervoso centrale e in alcuni tessuti periferici, ma le sue funzioni non sono chiaramente stabilite..
Antagonisti
L'antagonista universale di questi recettori è l'atropina, un alcaloide estratto dalla pianta Belladonna atropa, che si lega ad essi con un'elevata affinità, che rappresenta un criterio per differenziarli dai recettori nicotinici insensibili a questa molecola.
Esiste un gran numero di altre sostanze antagoniste che si legano a diversi tipi di recettori muscarinici con diverse affinità. La combinazione di diversi valori di affinità per alcuni di essi è servita proprio per l'inclusione di questi recettori in una o nell'altra delle categorie descritte..
Un elenco parziale di altri antagonisti includerebbe: pirenzepina, metoctramina, 4-DAMP, himbazina, AF-DX 384, tripitramina, darifenacina, PD 102807, AQ RA 741, pFHHSiD, MT3 e MT7; tossine queste ultime contenute rispettivamente nei veleni dei mamba verdi e neri.
I recettori M1, ad esempio, hanno un'elevata sensibilità per la pirenzepina; il M2 da triptramina, metoctramina e himbazina; gli M3 di 4-DAMP; gli M4 sono strettamente correlati alla tossina MT3 e anche all'hibazina; gli M5 sono molto simili agli M3, ma rispetto ad essi sono meno legati da AQ RA 741.
Riferimenti
- Ganong WF: Neurotrasmettitori e Neuromodulatori, in: Revisione di fisiologia medica, 25a ed. New York, McGraw-Hill Education, 2016.
- González JC: Ruolo dei recettori muscarinici nella modulazione della trasmissione GABAergica nell'ippocampo. Memoria per qualificarsi al titolo di dottore. Università Autonoma di Madrid. 2013.
- Guyton AC, Hall JE: Rythmical excitation of the Heart, in: Libro di testo di fisiologia medica , 13 ° ed; AC Guyton, JE Hall (a cura di). Philadelphia, Elsevier Inc., 2016.
- Piper HM: Herzerregung, in: Physiologie des Menschen mit Pathophysiologie, 31th ed; RF Schmidt et al (eds). Heidelberg, Springer Medizin Verlag, 2010.
- Schrader J, Gödeche A, Kelm M: Das Hertz, in: Fisiologia, 6a ed; R Klinke et al (eds). Stoccarda, Georg Thieme Verlag, 2010.
- Siegelbaum SA, Clapham DE, Schwartz JH: Modulation of Synaptic Transmission: Second Messengers, In: Principles of Neural Science, 5a ed; E Kandel et al (eds). New York, McGraw-Hill, 2013.

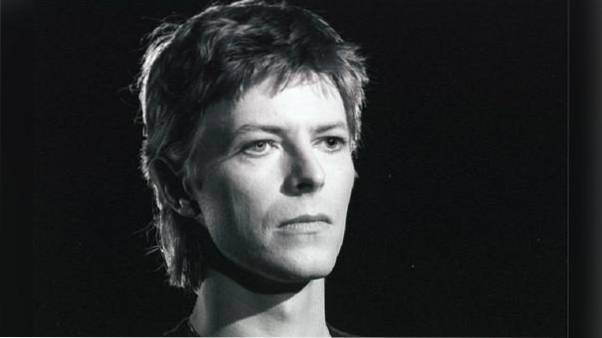

Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.