
Caratteristiche, funzioni, derivati dell'esoso
UN esoso è un carboidrato che ha sei atomi di carbonio e la cui formula empirica è C6H12O6. Carboidrati o saccaridi (dal greco, sakcharon = zucchero) sono poliidrossi-aldeidi o poliidrossi-chetoni.
In natura, il monosaccaride più abbondante è il glucosio, uno zucchero a sei atomi di carbonio, chiamato anche destrosio. La biosintesi del glucosio avviene dall'anidride carbonica e dall'acqua attraverso la fotosintesi.
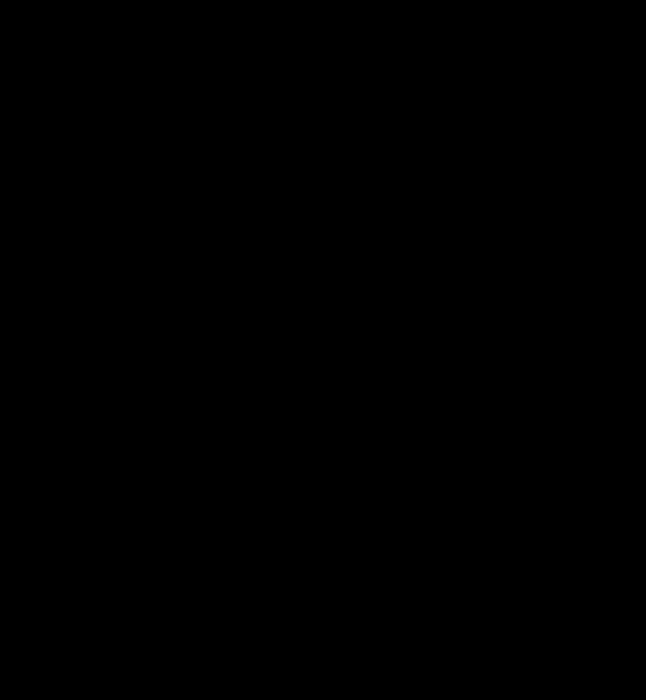
Nelle piante, dal glucosio, avviene la sintesi della cellulosa, un polisaccaride strutturale, e dell'amido, un polisaccaride di riserva. Negli organismi eterotrofi, l'ossidazione del glucosio è la via metabolica centrale per la produzione di energia.
Indice articolo
- 1 Caratteristiche
- 1.1 Gli esagoni hanno conformazioni differenti
- 1.2 Gli esosi possono formare legami glicosidici
- 1.3 Esosi e reazioni di riduzione dell'ossidazione
- 2 Derivati di esosi
- 3 esosi più comuni in natura e loro funzioni
- 3.1 Glucosio
- 3.2 fruttosio
- 3.3 Galattosio
- 3.4 mannosio
- 3.5 Ramnosa
- 4 Riferimenti
Caratteristiche
Gli esosi possono essere di due tipi: 1) aldosi (o aldoesosi), in cui il carbonio 1 (C-1) è una funzione aldeidica; o 2) chetosi (o aldocetosi) in cui il carbonio 2 (C-2) è una funzione cheto. Il resto degli atomi di carbonio sono alcoli secondari o primari.
In aldohexosi tutti gli atomi di carbonio sono chirali, tranne il carbonio 1 (C-1) e il carbonio 6 (C-6), cioè hanno quattro centri asimmetrici. Nella chetoesosi ci sono tre centri asimmetrici, che sono C-3, C-4 e C-5..
In natura, gli zuccheri come gli esosi con la configurazione L sono meno abbondanti degli zuccheri con la configurazione D..
La funzione aldeidica o funzione cheto degli esosi reagisce con un gruppo idrossile secondario, in una reazione intramolecolare, per formare emiacetali ciclici o emichetali. Gli zuccheri ciclici a sei membri sono piranoici e gli zuccheri a cinque membri sono furanosi.
Nello zucchero ciclico, il carbonio carbonilico dei gruppi aldeidico e cheto diventa un nuovo centro chirale, chiamato carbonio anomerico. La configurazione di questo carbonio può essere alfa o beta, cioè produce due anomeri.
Gli esosi hanno conformazioni differenti
I sei atomi che compongono le piranosi non sono planari ma hanno due conformazioni a sedia in cui occupano ingombranti sostituenti: a) posizioni equatoriali ob) posizioni assiali. Queste conformazioni possono essere interconvertite senza rompere i legami covalenti..
Le interazioni stereochimiche tra i sostituenti dell'anello influenzano la stabilità relativa di queste conformazioni. Pertanto, la conformazione più stabile è quella in cui il gruppo più numeroso occupa una posizione equatoriale..
La reattività chimica di un certo gruppo è influenzata dalla sua posizione conformazionale. Un esempio è il gruppo idrossile (-OH) che, quando occupa la posizione equatoriale, è più facilmente esterificato rispetto a quando occupa la posizione assiale.
Il β-Il D-glucosio, un aldoesosio, ha tutti i sostituenti in posizione equatoriale, il che li rende più suscettibili all'esterificazione. Questa reazione è importante per la formazione di legami covalenti tra gli zuccheri. Questo potrebbe spiegare perché β-Il D-glucosio è lo zucchero più abbondante in natura.
Gli esosi possono formare legami glicosidici
Le unità monosaccaridiche, come gli esosi, possono essere legate covalentemente attraverso legami O-glicosidici formati quando il carbonio anomerico di una molecola di zucchero reagisce con il gruppo idrossile di un'altra molecola di zucchero. Il risultato di questa reazione è la formazione di un acetale da un emiacetale.
Un esempio è la reazione di C-1, carbonio anomerico di α-D-glucopiranosio con il gruppo idrossile di C-4 di un altro β-D-glucopiranosio. Da esso è formato α-D-glucopiranosil- (1®4) -D-glucopiranosio.
La reazione di legame glicosidico comporta la rimozione di una molecola d'acqua, chiamata reazione di condensazione. La reazione inversa è l'idrolisi e la rottura del legame glicosidico.
Esosi e reazioni di riduzione dell'ossidazione
Gli zuccheri il cui atomo di carbonio anomerico non ha formato legami glicosidici sono chiamati zuccheri riducenti. Tutti i monosaccaridi, come gli esosi glucosio, mannosio e galattosio, sono zuccheri riducenti. Questo perché gli aldosi o le chetosi possono donare elettroni, o ridurli, a un agente ossidante..
Un test classico per gli zuccheri riducenti viene eseguito con i reagenti Fehling (o Benedict) e Tollens. Ad esempio, uno zucchero riducente può ridurre l'Ag+ presente in una soluzione di ammonio (reagente di Tollens). Questa reazione produce argento metallico sul fondo del recipiente in cui è avvenuta la reazione..
Attraverso una reazione catalizzata dall'enzima glucosio ossidasi, il carbonio anomerico del D-glucosio viene ossidato perdendo una coppia di elettroni e l'ossigeno viene ridotto ricevendo una coppia di elettroni. Questa reazione ha due prodotti: D-glucone-d-lattone e perossido di idrogeno.
Attualmente, la concentrazione di glucosio nel sangue è determinata da un test che utilizza glucosio ossidasi e perossidasi. Quest'ultimo enzima catalizza una reazione di riduzione dell'ossidazione.
I substrati della perossidasi sono il perossido di idrogeno e una sostanza cromogena, che viene ossidata. Questa reazione può essere quantificata utilizzando uno spettrofotometro..
Derivati degli esosi
Esistono molti derivati degli esosi il cui gruppo idrossile è sostituito da un altro sostituente. Ad esempio, il gruppo idrossile C-2 di glucosio, galattosio e mannosio viene sostituito con un gruppo amminico, formando rispettivamente glucosamina, galattosamina e mannosamina..
Frequentemente, il gruppo amminico si condensa con acido acetico, formando N-acetilglucosamina. Questo derivato della glucosamina si trova nella parete cellulare dei batteri.
Un derivato della N-acetilmannosamina è l'acido N-acetilneuraminico, noto come acido sialico. Quest'ultimo è presente nelle glicoproteine e nei glicolipidi sulla superficie delle cellule, avendo un ruolo nel riconoscimento da parte di altre cellule..
L'ossidazione specifica del gruppo alcolico primario, C-6, delle aldoesosi glucosio, galattosio e mannosio produce acidi uronici. Questi prodotti sono acido D-glucuronico, acido D-galatturonico e acido D-mannuronico, che fanno parte di molti polisaccaridi.
Gli acidi uronici possono subire esterificazione intramolecolare. Forma lattoni di cinque o sei atomi. Ad esempio, l'acido ascorbico (vitamina C) viene sintetizzato dalle piante.
La sostituzione del gruppo idrossile (-OH) con un atomo di idrogeno in C-6 di L-galattosio o L-mannosio produce rispettivamente L-fucosio o L-ramnosio. L-fucosio si trova nelle glicoproteine e nei glicolipidi. L-ramnosio si trova nei polisaccaridi nelle piante.
Gli esosi più comuni in natura e le loro funzioni
Glucosio
Simbolo: Glc. È un aldoesosio o glucoesosio. L'enantiomero D-glucosio (simbolo D-Glu) è più comune dell'enantiomero L-Glc. D-Glc è presente nelle piante, nel miele, nell'uva e nel sangue degli animali. È una fonte di energia per gli esseri viventi. Serve come precursore per la sintesi di glicogeno, cellulosa, amido e lattosio.
Fruttosio
Simbolo: Fru. È un chetoesosio o fruttatoesosio. L'enantiomero D-fruttosio è comunemente noto come fruttosio. Questo zucchero si trova, ad esempio, nella frutta, nel miele e nello sperma.
Galattosio
Simbolo Gal. È un aldohexose o galatohexose. Il D-galattosio è più comune dell'L-galattosio. Il D-galattosio è lo zucchero del cervello. Raramente è gratuito. Di solito si trova in piante, animali e microrganismi sotto forma di oligosaccaridi e polisaccaridi.
Mannosio
Simbolo: Uomo. È un aldoesoso o mannoesosio. La forma D-mannosio è ampiamente distribuita nella manna e nell'emicellulosa. Si trova come un oligosaccaride N legato alle glicoproteine, formando rami.
Ramnosa
Simbolo: Rha. È un aldoesosio che si trova nei glicosidi delle piante, nei polisaccaridi delle gengive e delle mucillagini, nonché nella parete cellulare delle piante e nei flavonoidi.
Riferimenti
- Cui, S. W. 2005. Carboidrati alimentari: chimica, proprietà fisiche e applicazioni. CRC Press, Boca Raton.
- Nelson, D. L., Cox, M. M. 2017. Principi di biochimica di Lehninger. W. H. Freeman, New York.
- Rastall, R. A. 2010. Oligosaccaridi funzionali: applicazione e produzione. Revisione annuale della scienza e della tecnologia alimentare, 1, 305-339.
- Sinnott, M. L. 2007. Struttura e meccanismo di chimica e biochimica dei carboidrati. Royal Society of Chemistry, Cambridge.
- Stick, R. V., Williams, S. J. 2009. Carboidrati: le molecole essenziali della vita. Elsevier, Amsterdam.
- Tomasik, P. 2004. Proprietà chimiche e funzionali dei saccaridi alimentari. CRC Press, Boca Raton.
- Voet, D., Voet, J. G., Pratt, C. W. 2008. Fondamenti di biochimica - vita a livello molecolare. Wiley, Hoboken.



Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.